Intervista a Roberta Bruzzone, da Filippo Turetta e Garlasco al caso di Alessia Pifferi: "Mi ha devastata"
La criminologa analizza casi reali, smaschera il narcisismo patologico e racconta cosa significa davvero cercare giustizia sul campo, non in tv
C’è chi la teme, chi la ammira e chi vorrebbe essere lei, ma Roberta Bruzzone resta una sola. Psicologa forense, criminologa, esperta di profiling, è da oltre vent’anni una presenza lucida e da molti invisa nel panorama giudiziario e mediatico italiano. Dove molti chiacchierano, lei lavora. Dove altri si affidano all’emotività, lei porta metodo. Ha partecipato a casi che hanno scosso l’opinione pubblica (da Sarah Scazzi a Garlasco, da Cogne a casi più recenti come quello di Giulia Cecchettin e Alessia Pifferi), sempre con un approccio analitico, spesso scomodo, mai accomodante. Negli ultimi anni, con la docuserie Nella mente di Narciso (prodotta da La Casa Rossa, la seconda stagione è in onda su Rai 2 ma è per intero disponibile su RaiPlay), ha compiuto un’operazione rara e potente: portare nelle case degli italiani le dinamiche sottili e devastanti della manipolazione affettiva, delle relazioni tossiche, del narcisismo maligno. Senza indulgenza, senza romanzare, senza retorica. Stagione dopo stagione, episodio dopo episodio, Roberta Bruzzone ha mostrato come certi comportamenti, troppo spesso normalizzati o scambiati per “passione”, siano in realtà segnali d’allarme di relazioni pericolose che possono sfociare nella tragedia. L’intervista in esclusiva per Virgilio Notizie è un viaggio dentro il suo metodo, la sua visione, la sua esperienza diretta sul campo. Ma anche un ritratto raro e umano di una professionista che non si nasconde dietro la fama: parla dei casi che l’hanno segnata, delle minacce ricevute, della stanchezza, della moto come via di fuga, del suo bisogno irrinunciabile di verità. Un dialogo a tutto campo in cui Roberta Bruzzone non fa sconti a nessuno, né alla cronaca trasformata in spettacolo né ai sedicenti esperti da salotto e nemmeno a una società che ancora oggi fatica a riconoscere le radici profonde della violenza. Perché la giustizia, per Roberta Bruzzone, non è un concetto astratto: è un lavoro quotidiano, meticoloso, spesso ingrato, sempre necessario.
Cosa l’ha spinta a dedicare un’intera docuserie al narcisismo patologico, fino ad arrivare a tre stagioni?
“Perché è una problematica attualmente diffusissima. Ricevo ogni giorno tantissime richieste di aiuto da persone che, a seguito di un’analisi approfondita, si rivelano vittime di personalità con tratti narcisistici patologici. Credo che oggi il narcisismo maligno sia una delle emergenze relazionali più pericolose e sottovalutate. In moltissimi casi di femminicidio su cui ho lavorato direttamente, ho riscontrato la presenza di personalità con queste caratteristiche: uomini e in alcuni casi anche donne incapaci di accettare il rifiuto, dominati da una necessità ossessiva di controllo e da una fragilità interna devastante. Lavorare su questi casi mi ha mostrato quanto sia fondamentale riconoscere precocemente certi segnali. La capacità di anticipare la deriva relazionale può salvare vite. Stimolare quel tipo di personalità può innescare una spirale pericolosa fatta di controllo, manipolazione, umiliazione e, nei casi peggiori, violenza estrema. Per questo insisto tanto su questo tema: c’è un’enorme urgenza di fare chiarezza e diffondere consapevolezza. Bisogna sapere con chi si ha a che fare prima che sia troppo tardi”.
 US Roberta Bruzzone
US Roberta Bruzzone
La risposta del pubblico è stata fortissima. Secondo lei, cosa distingue questa docuserie da altri prodotti?
“Credo sia il mio modo di raccontare queste storie. La gente apprezza che io sia concreta, diretta, senza giri di parole. Cerco di rendere comprensibili anche concetti complessi. Il pubblico mi ascolta perché si fida, perché sente che so di cosa parlo. Non improvviso, non romanzesco: racconto i fatti, li analizzo con competenza. Non offro giudizi morali, ma strumenti per capire. Inoltre, credo che abbia fatto la differenza il fatto che io non abbia trasformato la sofferenza delle vittime in spettacolo. C’è rispetto, c’è precisione, e c’è l’intenzione vera di aiutare le persone a riconoscere certe dinamiche tossiche che troppo spesso vengono scambiate per amore”.
Nell’ultimo caso della seconda stagione, quello dell’omicidio di Arianna Flagiello, compaiono i familiari della vittima. È stata una scelta precisa quella di includere o escludere testimonianze dirette?
“Sì, è stata una scelta molto ragionata. Abbiamo deciso di dare spazio solo in alcuni casi a chi ha vissuto in prima persona la tragedia, perché è un elemento che va dosato con attenzione. Nel caso di Arianna Flagiello, ad esempio, era fondamentale ascoltare il padre e la sorella, perché sono stati testimoni diretti anche se inconsapevoli della progressiva distruzione psicologica che Arianna ha subito all’interno di quella relazione malata. La loro voce rafforza il racconto, dà corpo e spessore emotivo a una storia che altrimenti sarebbe potuta sembrare troppo distante. Ma non sempre è giusto coinvolgere i familiari: dipende dal tipo di narrazione e soprattutto dal rispetto per la sofferenza privata. Nella prossima stagione, nella puntata dedicata al caso di Alessandra Matteuzzi, sentiremo altre testimonianze dirette. Quando ci sono dinamiche manipolatorie forti, sentire chi le ha viste da vicino è prezioso per comprendere davvero il contesto”.
Spesso si chiede l’identikit del criminale ma esiste, invece, un identikit della vittima del narcisista?
“No, non esiste un identikit unico. E lo dico chiaramente perché è pericoloso pensare il contrario. Nella fase iniziale della relazione, quella del cosiddetto love bombing, una prima mossa di ipervalidazione, il narcisista patologico si presenta come il partner ideale: attento, devoto, premuroso. Chiunque può esserne attratto. È una fase ipnotica, altamente seduttiva. Certamente ci sono persone più vulnerabili, magari chi ha avuto relazioni disfunzionali precedenti, chi ha una forte insicurezza emotiva o una dipendenza affettiva. Ma la verità è che, in particolari momenti della vita, tutti possiamo essere catturati. Creare un profilo “tipo” della vittima è pericoloso perché chi non si riconosce in quel profilo rischia di abbassare la guardia. E invece nessuno è davvero al sicuro. Per questo insisto tanto nel lavorare sulla consapevolezza: la prevenzione non si basa sul riconoscersi in una vittima tipo, ma sull’imparare a leggere i segnali sin dall’inizio”.
Le famose red flag esistono davvero o sono solo parole?
“Esistono, esistono eccome. E sono fondamentali da riconoscere. Noi nella docuserie le analizziamo tutte, in tutte le declinazioni in cui possono presentarsi. Il narcisismo maligno può assumere molteplici forme: grandioso, vulnerabile, maschile, femminile. Non è una questione ideologica o di genere. Non raccontiamo solo uomini carnefici e donne vittime. Mostriamo anche casi in cui le donne sono narcisiste manipolatrici, in alcuni casi persino assassine. Le red flag più comuni riguardano il controllo, l’appropriazione dell’altro, la tendenza a utilizzare il partner per nutrire un vuoto interiore. All’inizio tutto questo può sembrare attenzione, cura. Ma è controllo camuffato da amore. È lì che bisogna imparare a distinguere: tra attenzione autentica e sorveglianza, tra affetto e possesso. Le red flag ci sono sempre, ma bisogna saperle leggere. E serve che qualcuno te le mostri, senza sconti, senza ambiguità”.
Rilavorando a questi casi di cui si era già occupata, c’è qualcosa che l’ha sorpresa o colpita nuovamente?
“In realtà no, perché si tratta di storie che avevo già analizzato a fondo in passato. In questa seconda stagione, come già nella prima o come sarà nella terza, ho semplicemente avuto l’opportunità di approfondire ancora di più aspetti che erano già chiari nella mia lettura precedente. Quello che ho voluto fare è stato mettere a fuoco certi passaggi fondamentali che, se ben compresi, aiutano il pubblico a cogliere la struttura psicologica e comportamentale di questi soggetti. Più che sorprendermi, quindi, è stato un lavoro di consolidamento di una visione già formata”.
Pensa che i narcisisti raccontati nella serie si siano visti e riconosciuti nei ritratti?
“Qualcuno sì, o meglio: qualcuno che li rappresenta si è sentito toccato. Un esempio concreto riguarda il caso di Mirto Milani, uno degli imputati nel delitto Ziliani, che abbiamo trattato nella prima stagione. Il suo avvocato ci ha contattati per esprimere fastidio su come abbiamo descritto il suo assistito. Ma io non lavoro su opinioni, lavoro su comportamenti. E i comportamenti di Milani, come li ho potuti osservare e analizzare accedendo all’intero incartamento processuale, rivelano tratti narcisistici evidenti. Il suo ruolo all’interno della vicenda è stato, a mio avviso, centrale: una regia vera e propria, pur senza assolvere le sorelle Zani. Chi si rivede in quei ritratti spesso non lo ammette, ma può sentirsi “toccato”. E non sempre in positivo”.
La seconda stagione di Nella mente di Narciso si apre con il caso di Giulia Cecchettin. L’ha sorpresa la recente decisione di Turetta di rinunciare processo d’appello?
“No, non mi ha sorpresa affatto. Filippo Turetta è un narcisista covert, cioè un soggetto che agisce sotto traccia, apparentemente mite, ma profondamente manipolatorio e incapace di accettare qualsiasi frustrazione o perdita di controllo. L’idea di affrontare nuovamente un processo e, quindi, un’esposizione mediatica per lui è insopportabile, perché lo costringe a confrontarsi con la propria immagine pubblica e con un giudizio che non può gestire. Questi soggetti sono ipersensibili alla critica e tendono a sottrarsi quando sentono che non possono dominare la narrazione”.
Perché certi casi, come quello di Giulia Cecchettin, ci colpiscono più di altri?
“Ciò che rende certi casi ancora più potenti è l’identificazione collettiva: Giulia era una ragazza normale, poteva essere la figlia, la sorella, l’amica di chiunque. Questo genera un impatto enorme”.
E nel caso di Veronica Panarello, trattato sempre in questa seconda stagione, c’è lo stesso tipo di identificazione?
“No, con Veronica Panarello scatta un meccanismo diverso, quasi opposto. La gente tende a dire: “Io non potrei mai essere come lei”. È una forma di difesa psicologica, un tentativo di esorcizzare il terrore che il male possa annidarsi dentro qualcuno che apparentemente vive una vita normale. Veronica, fino al giorno prima, era una madre come tante, con un buon livello di adattamento sociale. Poi accade l’inimmaginabile. È proprio questo che inquieta: il male che si nasconde dietro la facciata della normalità. Le persone restano incollate a queste storie perché le spaventano e al tempo stesso le affascinano. E la verità è che la maggior parte di chi commette atti gravissimi non è il “mostro” stereotipato, ma qualcuno che fino al giorno prima avremmo potuto incontrare per strada o al supermercato”.
Cambia qualcosa nel suo approccio quando la vittima è un bambino?
“Assolutamente sì. Per me, sono i casi emotivamente più duri in assoluto. E non è solo una questione professionale: è umana, profonda, viscerale. Ho appena concluso la consulenza sul caso di Diana Pifferi, la bambina lasciata morire di stenti dalla madre Alessia. È stato un lavoro che mi ha devastata. Ricostruire cosa è accaduto, mettere insieme i dettagli, i silenzi, le omissioni, le responsabilità… tutto questo ha avuto un costo enorme per me, anche fisico. Dopo aver lavorato al caso ho sviluppato un raffreddore persistente, cosa che non mi accade mai, ma evidentemente il mio organismo ha reagito a quello che ho dovuto elaborare. Ci sono casi che ti lasciano addosso un dolore che non se ne va. E quelli che coinvolgono bambini sono sicuramente i più strazianti”.
Alessia Pifferi vorrebbe sposare ora la sua compagna di cella. La sorprende?
“No, non mi sorprende per niente. Conoscendo il suo profilo psicologico, è un comportamento perfettamente coerente. Alessia ha un bisogno continuo e patologico di essere al centro di una relazione sentimentale. Ha bisogno di sentirsi scelta, desiderata, indispensabile. Questo bisogno, purtroppo, è lo stesso che l’ha portata a sacrificare la vita di sua figlia. Oggi lo rivediamo in questa dinamica all’interno del carcere: non importa con chi, non importa dove, l’importante è essere dentro un legame, dentro una narrazione che la vede protagonista. E lei si nutre proprio di questo. È la cifra più riconoscibile della sua personalità”.
Si fa un gran parlare di educazione emotiva, affettiva e sessuale nelle scuole, ma le istituzioni sembrano sempre alzare un muro. Cosa ne pensa?
“Io credo che ci sia un pericolo in questo tipo di progetti: pensare che possano davvero risolvere le problematiche che sono ormai diffusissime. La verità è che i modelli relazionali si apprendono in famiglia. Fare un’oretta a settimana di educazione affettiva quando in casa si ricevono messaggi completamente distorti, distruttivi, alternativi… non serve a molto. E attenzione: non sto dicendo che parlarne a scuola sia inutile – anzi, parlarne è utile – ma non possiamo pensare che la scuola debba insegnare ai ragazzi a relazionarsi. Quello è un mandato familiare, prima di tutto. C’è anche un altro punto che non è secondario: chi dovrebbe portare avanti questi programmi? Siamo sicuri che verrebbero affidati a persone realmente capaci di trasferire competenze così delicate? Io, su questo, ho delle grosse perplessità. Considerando anche come funziona oggi il sistema scolastico e la preparazione su altre materie fondamentali, capiamo bene che il rischio è passare dalla padella alla brace. Serve una riflessione molto più seria, prima di lanciarsi in iniziative così complesse. Altrimenti si rischia di fare più danni che altro”.
Oggi cronaca, intrattenimento e spettacolo sembrano mescolarsi: Fabrizio Corona, l’avvocato Lovati che punta al Grande Fratello Vip e potremmo continuare a lungo…
“La trovo una deriva pericolosissima e inesorabile. Siamo arrivati a un punto in cui chiunque si sente autorizzato a parlare di temi complessi come la salute mentale, la criminologia o la giustizia, spesso senza alcuna competenza specifica. E il problema non è solo legato alla superficialità, ma anche al fatto che certe persone lo fanno per convenienza, per visibilità, per sfruttare il dolore altrui. Abbiamo visto personaggi coinvolti in inchieste giudiziarie gravi, altri già condannati per truffa, che si riciclano nel mondo del true crime. Alcuni si spacciano per esperti e vanno a cercare le famiglie delle vittime solo per ottenere visibilità. Serve un limite, serve una regolamentazione chiara. Non possiamo lasciare certi argomenti in mano a chi non ha né la preparazione né l’etica per trattarli. Personalmente, ci sono soggetti a cui non affiderei neanche il sacchetto della spazzatura da portare fuori, figuriamoci il racconto di storie così drammatiche e delicate”.
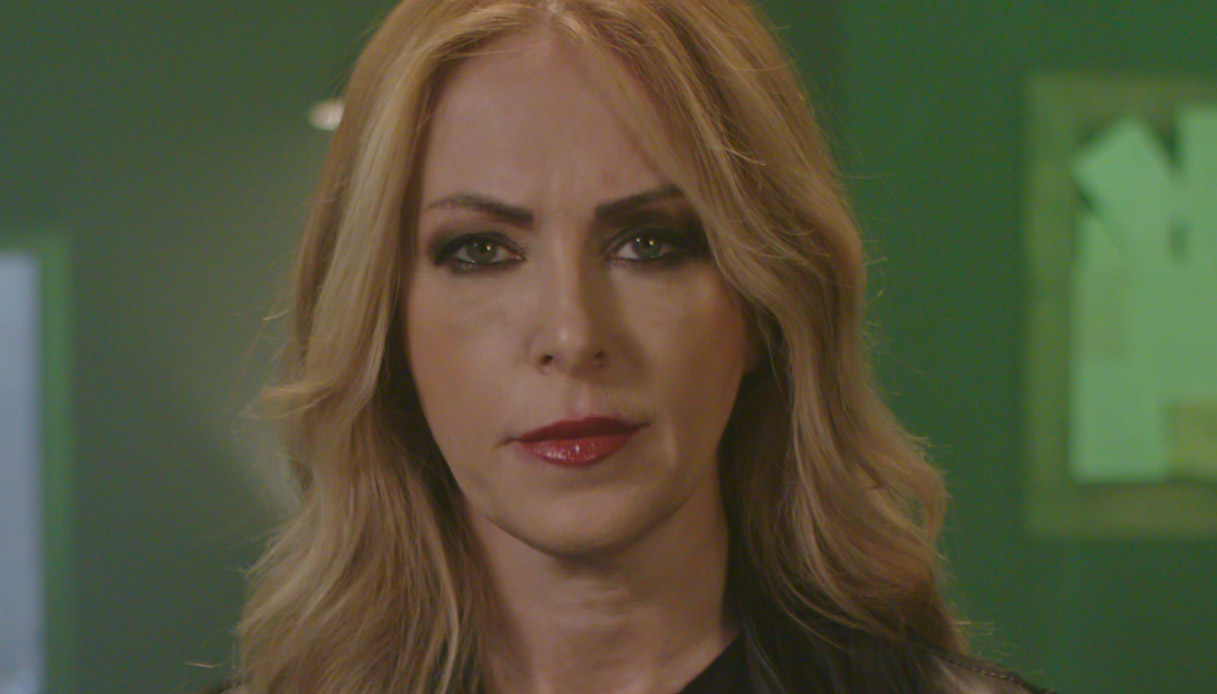 US Roberta Bruzzone
US Roberta Bruzzone
Cosa pensa delle serie tv che trasformano casi reali in fiction, come quelle su Sarah Scazzi, Amanda Knox o Melania Rea? Per Avetrana l’hanno contattata dal momento che avrebbe potuto essere anche lei parte del racconto (Michele Misseri confessò alla dottoressa Bruzzone che l’assassino di Sarah Scazzi era la figlia Sabrina, ndr)?
“Non le approvo. Per me c’è una differenza netta tra una docuserie ben fatta, basata su fonti attendibili e finalizzata a informare, e la trasformazione di un caso di cronaca in una fiction. Lì entra in gioco un altro livello: l’intrattenimento. E onestamente, se fossi un familiare delle vittime coinvolte, mi sentirei devastata nel vedere il dolore della mia famiglia spettacolarizzato per l’audience. La linea è sottile, ma esiste, e secondo me non andrebbe mai oltrepassata. Se mi chiedessero di partecipare a una produzione di quel tipo, la mia risposta sarebbe no. E, infatti, per la serie su Avetrana, non mi hanno contattata ma, anche se lo avessero fatto, avrei rifiutato. Non mi interessa far parte di quel tipo di narrazione”.
In questi giorni è stata conferita la laurea ad memoriam a Sara Campanella. Il suo assassino presentava tratti narcisistici?
“Sì, assolutamente. Anche se nessuno di noi ha potuto valutarlo direttamente, basta analizzare le sue condotte. Stefano Argentino era un soggetto con una chiara fragilità narcisistica, incapace di tollerare il rifiuto. Aveva tratti ossessivi, un bisogno disperato di controllo e un ego talmente fragile da crollare di fronte a un no. Non riusciva ad accettare l’idea di essere stato rifiutato. Questo è un tratto distintivo del narcisismo maligno: il rifiuto viene vissuto come una minaccia esistenziale, e può generare reazioni estreme”.
Considerando il suicidio di Argentino in carcere, c’è stata una cattiva gestione del caso, secondo lei?
“Dispiace che Sara non abbia sporto denuncia, perché forse avrebbe avuto una possibilità in più per proteggersi. Ma il dolore più grande lo vivono oggi i suoi familiari. Con il suicidio dell’assassino, il procedimento penale si è estinto e non ci sarà mai una sentenza di condanna. Nessuna giustizia piena, nessun riconoscimento formale del male subito. E questo è devastante. Chi lavora nel nostro settore sa bene che soggetti con quella fragilità narcisistica, messi davanti alla vergogna pubblica e all’impossibilità di controllare la narrazione, presentano un rischio suicidario elevatissimo. È chiaro che qualcosa non ha funzionato anche in carcere. Non entro nel merito operativo, ma come professionista non posso non rilevare che l’epilogo ha lasciato tutti con l’amaro in bocca”.
Anche in casi come quello di Monreale, dove dei giovani sparano in piazza in maniera impavida, c’è narcisismo?
“Sì, assolutamente. Prendere un’arma e fare fuoco in mezzo a una piazza non è solo un atto di violenza, ma un’esibizione di potere. È la manifestazione estrema e grandiosa del bisogno di controllo e visibilità. Chi compie gesti del genere spesso vuole dimostrare di valere qualcosa, di contare, di lasciare un segno. C’è una componente narcisistica molto forte nel voler imporre la propria volontà con un atto così spettacolare e distruttivo”.
A tal proposito, che cosa pensa di serie come Mare Fuori, che raccontano la violenza come intrattenimento?
“Non le approvo. Penso siano contenuti pericolosi. Non hanno un effetto deterrente, anzi: possono generare emulazione. Mostrano modelli di vita disfunzionali, criminali, e in certi contesti possono diventare addirittura fonte di ispirazione per ragazzi che non hanno figure adulte di riferimento forti. Non è colpa delle serie in sé, ma del contesto in cui vengono assorbite. In una società dove la famiglia è spesso disgregata e la scuola non ha gli strumenti per intervenire, un adolescente può guardare a quei personaggi come modelli di successo, anche se criminali. E questo è pericoloso. È come gettare una sigaretta accesa in un bosco arido. Se ci sono già tutte le condizioni, l’incendio scoppia”.
Cosa l’ha attratta della criminologia e cosa la trattiene ancora oggi nel campo?
“Amo il mio lavoro perché mi dà la possibilità di contribuire a qualcosa di concreto: la ricerca della verità. Faccio un esempio recente: il GIP ha rigettato la richiesta di patteggiamento di Emiliano Volpe, il ragazzo accusato di istigazione al suicidio nei confronti di Andrea Prospero. Io sono consulente della famiglia di Andrea. Quando abbiamo appreso della richiesta di patteggiamento, siamo rimasti sconcertati. Ma grazie al lavoro della difesa e alla consulenza tecnica che ho redatto, siamo riusciti a far rigettare quella richiesta. Questo per me è il senso di tutto: sapere che il mio contributo può fare la differenza, può portare giustizia a chi l’ha subita. È questo che mi motiva ogni giorno”.
Ha mai pensato di mollare? Qualcuno ha cercato di metterle il bastone tra le ruote?
“Mollare? Mai. Ho avuto tanti ostacoli, certo. E continuo ad averne. Ci sono persone che mi attaccano quotidianamente, spesso per motivi miserabili come l’invidia. Ma io vado avanti. Sono abituata. Molti di quelli che ci hanno provato non sono finiti bene, perché non avevano nulla di solido su cui basare i loro attacchi. Erano solo mosse malevole, sgangherate, senza fondamento. E io sono una che non molla mai”.
Ha mai avuto paura lavorando su un caso?
“Ho ricevuto minacce, sì. E sono tuttora vittima di atti persecutori. Sono coinvolta in due procedimenti come persona offesa, e altri si stanno aprendo. Ci sono anche soggetti che hanno minacciato i miei affetti più cari. È per questo che ormai ai miei eventi pubblici sono sempre accompagnata da un servizio di sicurezza personale. È diventato indispensabile. Ma nonostante questo, continuo a fare il mio lavoro. Non mi lascio intimidire”.
C’è stato un caso lungo tutto la sua carriera che l’ha segnata più di altri?
“Non in senso personale. Riesco a mantenere una separazione netta tra la mia vita e il mio lavoro. Ma ci sono casi che mi hanno richiesto uno sforzo enorme, sia sul piano tecnico sia emotivo. E che lasciano un segno, anche se non ti travolgono. Sono storie che si portano dietro un peso, una complessità, che richiedono tutto quello che hai da dare”.
Riceve tantissime richieste di consulenza. Fiuto a parte, come sceglie i casi di cui occuparsi?
“Ho uno studio ben organizzato, con diversi collaboratori. Valutiamo ogni richiesta secondo parametri precisi. Quando arriva un nuovo caso, analizziamo la documentazione, ne discutiamo insieme, e decidiamo se prenderlo in carico. Non è solo una questione tecnica, ma anche etica. Prendiamo in considerazione la sostenibilità del caso, la possibilità di offrire un contributo reale, e la presenza o meno di strumentalizzazioni. È un processo molto rigoroso”.
La psicologia forense in Italia è diversa rispetto ad altri Paesi?
“Sì, e le dirò di più: secondo me in Italia siamo messi meglio. Sto lavorando a casi anche in Francia, Germania e Belgio, e devo dire che ho trovato colleghi molto poco preparati. Utilizzano metodologie che non sono scientificamente valide, ignorano aspetti fondamentali della letteratura internazionale. In alcuni casi sono rimasta allibita. Paradossalmente, nel nostro Paese, dove spesso si pensa che tutto vada male, ci sono professionisti molto più solidi. Quindi sì, abbiamo molto da insegnare”.
Qual è la bugia o il falso mito sul suo lavoro che la infastidisce di più?
“Che tutti quelli che parlano in tv siano esperti. Non è così. Molti non hanno mai messo piede in un’aula di tribunale, né tantomeno lavorato su una scena del crimine. Raccontano i casi, ma non li conoscono davvero. Un conto è parlarne, un altro è farli. E poi c’è questa aspettativa surreale che le indagini debbano essere perfette, come in CSI. Non esiste l’indagine perfetta. Esistono persone preparate che fanno del loro meglio, ma anche loro possono sbagliare. Chi pretende perfezione dimostra di non sapere come funziona davvero questo mondo. E questo, sì, mi infastidisce molto”.
Se pensiamo a lei, la vediamo in motocicletta. Cosa rappresenta per lei la moto?
“È un modo per staccare, per pulire la mente. Quando il carico mentale diventa troppo, salgo in moto e lascio andare tutto. Ho fatto tanti viaggi, in Europa e negli Stati Uniti. Il più bello è stato attraversare il West americano: Nevada, California, Arizona, la Valle della Morte. Un’esperienza faticosa ma liberatoria. È in quei momenti che riesco a essere davvero me stessa, senza sovrastrutture.
Che sensazione ha quando accende la moto?
“È come dire: “Adesso posso respirare. Adesso posso essere io”. È una sensazione di libertà pura. Non c’è niente di costruito, niente da dimostrare. Solo strada, vento, e silenzio dentro la testa”.
“Riesco a essere me stessa”: chi è Roberta?
“Roberta è una brava persona. Molto più umile di quanto molti pensano. La mia sicurezza viene spesso scambiata per arroganza, ma non lo è. Amo profondamente il mio lavoro, voglio bene alle persone che mi stanno accanto, sono protettiva e leale. Detesto l’ingiustizia, l’ipocrisia e la mediocrità. Sono una persona semplice, diretta, ma se mi colpisci ingiustamente… divento una belva. Non perdono la menzogna, la calunnia, la manipolazione. Se qualcuno oltrepassa certi confini, per me diventa una missione smascherarlo. Finché non ho ottenuto giustizia, non mollo. È più forte di me”.
Qual è il suo ultimo pensiero la sera prima di dormire?
“Il mio gatto che mi salta addosso e vuole dormire con me. Mi addormento serena, senza pensieri, con la coscienza pulita. E so che non tutti possono dire lo stesso. Chi mi odia forse non ha questo privilegio. Io invece sì. E ne vado fiera”.
Tanti nemici tanta gloria?
“Non credo di avere tanti nemici, perché in realtà sono poi, alla fine, quattro squilibrati, sempre i soliti. Credo francamente che meriterei nemici migliori. Un po’ più stimolanti, ecco. Questo sì. Perché quelli con cui ho a che fare, devo dire, insomma… il livello è talmente infimo che non è neanche troppo difficile averci a che fare: contrastare certa gente è quasi imbarazzante da quanto è facile”.
 US Roberta Bruzzone
US Roberta Bruzzone
